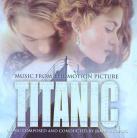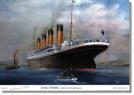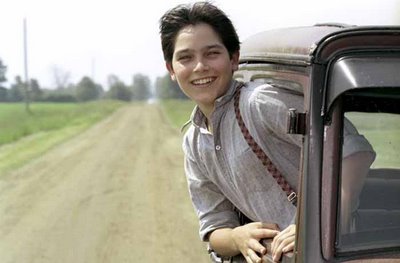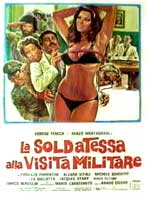
Negli anni '70 fu tutta una fioritura di filmetti della c.d. commedia all'italiana sull'esercito e i militari. Cominciarono Franco Franchi e Ciccio Ingrassia col "sergente Rompiglioni", una mini-saga credo in due o tre "puntate" nella quale già faceva capolino, tra i comprimari, Aldo Carotenuto, un attore di qualità che come tanti, in quegli anni, per guadagnarsi la pagnotta dovette accettare parti e particine in quei filmetti.
Carotenuto fu poi il trait d'union con le commedie sexy, che di tanto in tanto le TV locali (che però spesso ora trasmettono sul satellite, potere del digitale globalizzante!) ripropongono: "La dottoressa del distretto militare", "La soldatessa", "La soldatessa alle grandi manovre" e compagnie (e battaglioni) via cantando.
Negli stessi anni il personaggio radiofonico del colonnello Buttiglione diede vita a sua volta a un film e vari sequel, il primo interpretato da un attore caratterista francese Jaques Duphilo, gli altri da Aldo Maccione (che era poi uno dei "Brutos" complesso comico-vocale degli anni '60, quello in cui il più brutto di tutti prendeva immancabili scoppole dagli altri: mi riferisco a "misteri gloriosi della TV" noti solo agli anzianotti come me).
Regina incontrastata delle caserme a luci "rosse" (ma forse solo "rosa", visto che si vedevano nudi abbastanza "casti", rispetto a quelli attuali) era Edwige Fenech, ora splendida quasi sessantenne ancora molto bella e piena di glamour, che fece sognare almeno due generazioni di adolescenti, dividendoli nei due "partiti" dei fenechiani e dei bouchetiani (Barbara Bouchet era l'alternativa bionda della valchiria dalla chioma nera).
Indimenticabili protagonisti di quei film erano poi, oltre a Carotenuto, Aldo Montagnani (altro attore di teatro di qualità costretto ad arrotondare la mesata con quei film) e Alvaro Vitali (interprete della saga di "Pierino").
Quale era il mondo di quella vita militare?
Camerate in cui le reclute subivano atroci scherzi dai "nonni", si accollavano le corvee (immancabile la pulitura delle latrine), marcavano visita con i più ingegnosi sistemi; sottufficiali frustrati, generalmente tonti e prepotenti; ufficiali, colonnelli, generali tromboni.
Diciamolo: per molti anni l'esercito (onnicomprensivamente parlando delle tre armi) è stato visto come lo specchio della peggiore Italia, la sentina di ogni incompetenza e cialtroneria, una cosa sostanzialmente inutile e autoreferenziale.
Giocava in quel sentimento la memoria della guerra perduta, di ufficiali che non si dimostrarono all'altezza, lo scarsissimo sentimento nazionale, un amor di Patria diventato imbarazzante quasi come un'orientamento pedofilo, la naturale propensione italica a defilarsi, uno spirito "guerresco" del tutto evaporato.
Poi sono iniziate le missioni di pace: era il 1982 e un contingente italiano, al comando del generale Franco Angioni, fu spedito in un Libano martoriato dalla guerra civile tra musulmani e cristiano-maroniti (con i relativi sponsors siriano e israeliano) come forza d'interposizione sotto l'egida dell'ONU.
Ancora un decennio, e un'altro contingente italiano andò il Somalia nel quadro di una forza multinazionale che tentò, vanamente, di rimettere ordine nel paese del corno d'Africa sbrindellato pezzo a pezzo tra bande al servizio dei c.d. signori della guerra.
Vennero poi le missioni nei Balcani, la guerra "umanitaria" per proteggere le popolazioni del Kossovo (a proposito, lì l'Italia partecipò attivamente a missioni belliche, con le sue basi e i suoi aerei che andarono a bombardare i serbi...), il piccolo contingente di Timor est, la partecipazione a "enduring freedom", ossia al consolidamento della pace in Afganistan, e quella, da ultimo, tesa allo stesso obiettivo nell'Iraq meridionale.
Fu allora che scomparve l'immagine macchiettistica delle nostre forze armate, e iniziammo a celebrare i primi funerali dei primi militari caduti in azione dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Fu così che la parata del 2 giugno, che aveva conosciuto alterne vicende dalla sua istituzione nel 1948, riprese vigore e diventò un appuntamento di un qualche significato e di una certa solennità.
I contromanifestanti piddiccini, rifondaroli e verdi (solecheghigna, più che ridere) naturalmente non sanno niente di tutto questo, né della distinzione tra guerra d'aggressione, guerra difensiva, missioni di polizia internazionale, missioni umanitarie.
I loro leader, da Diliberto a Pecoraro Scanio, citano come sacro manifesto del pacifismo unilaterale e unidirezionale l'art. 11 della Costituzione.
Ma che dice l'art. 11 della Costituzione?
Che l'Italia, uscita come tutta l'Europa e il Mondo intero dalle macerie di una guerra terribile come la seconda mondiale, "ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli", ossia rifiuta la guerra di aggressione, volta alla conquista, e ripudia la guerra "come strumento di risoluzione delle controversie internazionali", ovvero l'escalation bellica tra nazioni che accampano reciproche pretese.
Rientrano in questo solenne paradigma le missioni di polizia internazionale, le missioni umanitarie, le missioni d'interposizione tra belligeranti?
A me non pare del tutto evidente.
Prendiamo i tre esempi: Kossovo, Afganistan, Iraq.
In Kossovo, si trattava di evitare una carneficina e una nuova pulizia etnica dopo quelle che Milosevic e i suoi soci avevano sostenuto in Bosnia e in altri pezzi della ex Jugoslavia.
In Afganistan, di stanare dai loro santuari i talebani e i qaedisti, coautori dell'11 settembre e di tante successive stragi.
In Iraq, di deporre un dittatore che aveva a sua volta fatto operazioni di pulizia etnica (i massacri dei curdi), sanguinose repressioni, appoggiando il terrorismo palestinese e islamico.
Sono state queste guerre di aggressione? Erano rivolte alla conquista di quelle nazioni e ad attentare alle libertà dei loro popoli? O non piuttosto a liberare quei popoli dal giogo di dittature sanguinarie e oscurantiste?
E' troppo sperare che queste cose le sappiano e ci riflettano i ragazzotti dei centri sociali; dovrebbero saperlo i "combattenti e reduci" ultracinquantenni della sinistra radical-kitch che amoreggiano con Castro e i neodittatori sudamericani; lo sanno ma hanno il loro tornaconto politico ad alimentare pacifismo e confusione i leader politici piddiccini, rifondaroli, verdi.
Di certo lo sa anche il Presidente della Camera, che ieri, imbarazzato e stranito, ha seguito la sfilata dal palco delle autorità per dovere istituzionale, cercando di rimanere "di lotta" (almeno un pochino) col distintivo arcobalenista sul bavero della giacca.
Non credevo di poter mai condividere un giudizio di Bondi (che trasfonde nella sua fede nel berlusconismo quella stessa cecità che molti trasfondono nella fede comunista e pacifista).
Ma Bondi ha detto ieri una cosa giusta: "Il modo con cui Bertinotti adempie alle sue responsabilità di presidente della Camera è imbarazzante e fa precipitare l'Italia nel ridicolo".
Chissà che non se ne sia accorta anche "Lady" la cagnetta meticcia mascotte dei carabinieri, in parata anche lei tra i monumentali cavalli dell'Arma.
Le cronache non lo dicono, ma mi piace immaginare che arrivata all'altezza del Presidente di lotta e di governo gli abbia abbaiato festante. E magari ha alzato la zampina posteriore, accostandosi al palco.